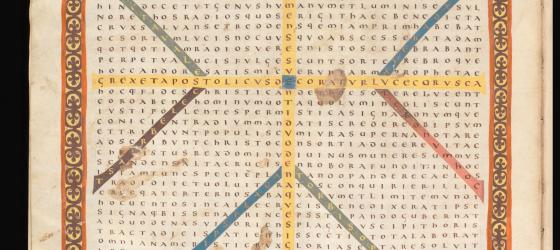Gli Atti di Latina Didaxis XXXVI sono pubblicati in open access nella sessione Orizzonti - Dossier di Classicocontemporaneo 10 (2024), a cui rimandano i collegamenti presenti in questa pagina; alla redazione di Classicocontemporaneo va la gratitudine del CeLD.
La revisione e l'elaborazione dei testi per la pubblicazione è stata curata da Alice Bonandini.
Alice Bonandini, Biagio Santorelli, Introduzione
La trentaseiesima edizione di Latina Didaxis si è tenuta il 14 e 15 aprile 2023 presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (Dafist) dell’Università di Genova e il Liceo classico ‘Andrea D’Oria’, a testimonianza dell’integrazione tra ricerca accademica e insegnamento nella scuola secondaria che tradizionalmente anima questa iniziativa, grazie anche al costante sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale. Questa edizione è stata dedicata a un tema centrale nella didattica del latino: il lessico.
Alessandro Re, Tipologia e stilistica della composizione nominale latina
La composizione nominale latina è un aspetto della linguistica che, nel corso dei secoli, è stato affrontato secondo paradigmi assai diversi allo scopo di comprendere i principi che vi sono sottesi e quali risvolti essa abbia avuto dal punto di vista stilistico-filologico. Sin dal IV secolo a.C. Platone e Aristotele si sono interrogati circa la forma e il valore dei composti nominali, ma è solo con Dionisio Trace che si giunge a una prima classificazione formale delle tipologie di nomi: in ambito romano, con l’eccezione di Varrone, il modello dionisiano è applicato anche alla lingua latina senza sostanziali modifiche concettuali. Solo con la conoscenza della grammatica antico-indiana muta la comprensione del fenomeno grazie all’introduzione di un principio di natura sintattica: il modello paniniano è così applicato anche al latino per approfondire la classificazione dei composti nominali. Nel XX secolo, prima lo strutturalismo e poi la grammatica generativa ridefiniscono l’intera questione: in particolare, grazie alla construction grammar è possibile non solo individuare il rapporto tra la forma del composto e il suo significato ma anche istituire un legame tra la tipologia composizionale e il suo valore stilistico.
Anna Zago, Quot modis nomina componuntur? L’insegnamento dei grammatici latini sulla figura composita
L’articolo descrive e commenta i punti principali della dottrina grammaticale latina sulla composizione nominale, con particolare riferimento all’accidens della figura all’interno dei capitoli sul nome. Si analizzano poi tre argomenti fondamentali nella trattazione dei grammatici: i quattro modi della composizione; la definizione degli elementi corrupta opposti agli integra; la possibilità di moltiplicare la composizione
Martina Farese, Tra norma linguistica e prassi poetica. Composti nominali e giochi di parole in Varrone
L’articolo, prendendo le mosse dalle considerazioni espresse da Varrone nel De lingua Latina sulla differenza tra impositio e declinatio e sulla natura del genus compositicium, si propone di indagare l’incidenza del fenomeno linguistico della composizione nominale nelle Satire Menippee, allo scopo di mettere a confronto le formulazioni teoriche varroniane con la sua effettiva prassi letteraria e valutare dunque le peculiarità del sistema varroniano e la coerenza interna della sua produzione.
Michael Fontaine, Verba Genuina. Parole autentiche e parole “cheeky” in Plauto
Il contributo discute quattro giochi di parole presenti nelle commedie di Plauto, che riguardano i termini sicilicissitat nei Menecmi, pascite nella Mostellaria, adulescens nella Mostellaria e nel Poenulus e siccoculum nello Pseudolus. Dal momento che tre di questi vengono adoperati in modo impudente, con una percepibile insolenza, li ho scherzosamente definiti verba genuina, o «cheeky words».
Luigi Galasso, I composti in Ovidio: espressività e allusività
Come ha messo in rilievo Edward Kenney, Ovidio sfrutta al meglio le risorse espressive dei composti all’interno della sua produzione poetica, senza allontanarsi però dalla pratica diffusa degli altri augustei. I composti possono tuttavia avere di per sé anche un valore di immediata allusività: si studia in particolare il caso di Empedocle, che è prevalentemente reso presente attraverso e all’interno del rapporto complesso con Lucrezio.
Gabriella Moretti, Il gioco dei composti: Petronio e Marziale
Il fenomeno linguistico delle parole composte non ha attirato soltanto l’interesse dei grammatici, dato che le potenzialità insite nell’incontro e nella saldatura in un unicum fra parole diverse sono state esplorate anche letterariamente: giocando sull’ambiguità e per così dire sulla doppiezza congenita di queste forme, capaci quindi di andare nella direzione dell’enigma, del doppio senso e dell’effetto-sorpresa. Si esamineranno qui dei casi emblematici nel passo petroniano degli apophoreta a Sat. 56, e in diversi epigrammi di Marziale: in entrambi i casi, anche se in modo diverso, l’uso letterario dei composti e i giochi di parole che vi sono collegati non sembrano estranei a un influsso diretto della tradizione grammaticale.
Se si eccettuano le raccolte altomedievali di Simposio e dei poeti anglici (Aldelmo, Tatuino, Eusebio), il genere dell’indovinello appare assai poco testimoniato nella letteratura latina. In questo contributo vengono analizzati e discussi alcuni esempi di indovinelli anonimi, con una particolare attenzione a quelli dove la soluzione (o le soluzioni) può essere trovata solo attraverso un gioco di parole molto simile a quelli dell’enigmistica moderna.
Étienne Wolff, Composition, jeux de mots et créativité verbale chez Ausone
Ausonio ha una lingua particolarmente ricca e ama i giochi di parole. Dopo una breve rassegna delle parole composte in Ausonio, ci occuperemo dei giochi di parole prodotti dalla composizione, o nella forma di creazione lessicale umoristica, o come paronimia, o come rianalisi del composto, anche mescolate tra loro.